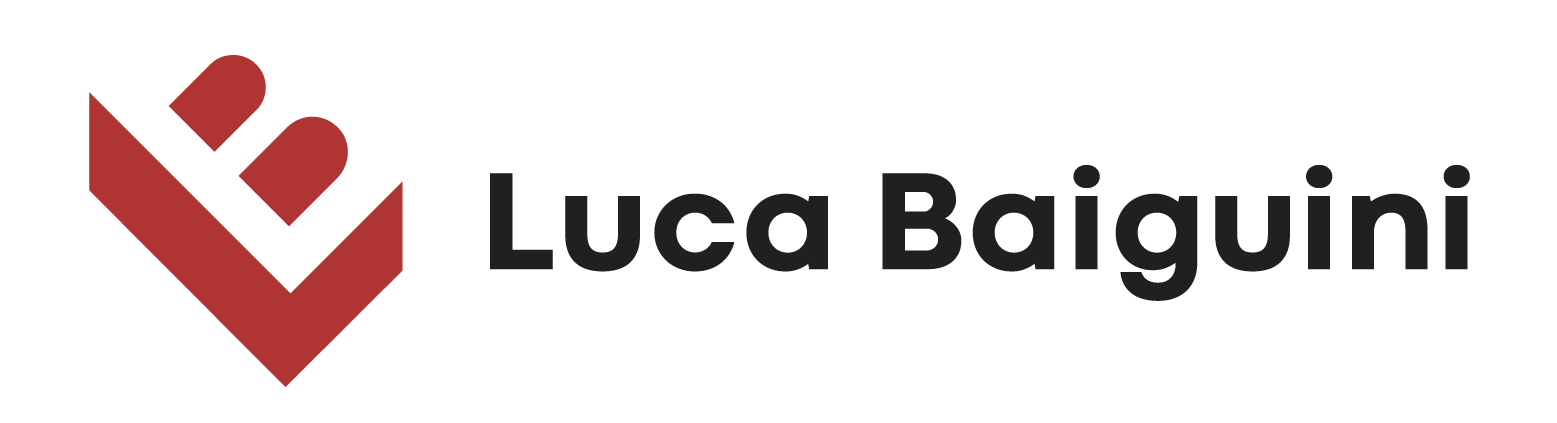Sui muri e sulla pulsione securitaria. Quindi, sulla rielezione di Trump.
Come fare a non commentarla? Sì, lei: la rielezione di Donald Trump.
Del resto, quale migliore occasione per esercitare un po’ di razionalità a posteriori farcita di qualche “l’avevo detto io”?
Come sapete, sono un politologo di formazione, ma da molti anni non mi occupo più di analizzare in dettaglio il potere politico: ho spostato la mia attenzione sulle dinamiche di potere nelle organizzazioni.
Le cose che dico, quindi, sono il frutto un po’ dei miei studi e un po’ di alcuni pensieri scambiati in questi giorni.
Li sintetizzo in due idee.
La prima è una cosa di cui parlo da un po’, la seconda è una cosa più recente, che la campagna elettorale e i suoi risultati hanno contribuito ad addensare e solidificare.
Uno
La lotta politica, almeno da una ventina d’anni a questa parte, è passata dall’essere uno scontro tra ideologie all’essere uno scontro tra narrazioni. Non mi è chiaro se questo sia avvenuto a causa del cambio dei media, oppure se il messaggio avrebbe seguito comunque questa traiettoria. Fatto sta che è avvenuto.
In questo non vedo differenze sostanziali tra gli schieramenti politici. Barak Obama, per dirne uno, ha interpretato perfettamente questo spostamento.
E se la priorità è dare in pasto personaggi, trame e sfide, allora è quasi naturale la personalizzazione della leadership politica.
Un’ideologia vive in chi la propone.
Una narrazione è chi la propone.
Due
Le sole narrazioni in grado di addensare consenso diffuso di questi tempi sembrano essere quelle basate sulla logica del nemico. Ne ho parlato ampiamente anche in Fate pace con il potere: l’impalcatura del consenso si regge su un messaggio forte veicolato dal leader: all’esterno del gruppo c’è un nemico pericoloso (o anche più di uno) e la priorità assoluta è la difesa dei valori, degli interessi, dei bisogni del gruppo dalla minaccia che esso rappresenta.
Se dovessi dare a queste narrazioni un’etichetta, sarebbe: narrazioni fondate sulla protezione, dove quest’ultimo termine può trovare le più diverse declinazioni.
L’avversario politico come minimo non è in grado di proteggere dal nemico, più spesso è in combutta con quest’ultimo.
Con un elemento distintivo, però, rispetto all’uso della logica del nemico in altri momenti storici: il pericolo rappresentato dalla presenza dei nemici non si traduce in una “chiamata alle armi”. Il solo momento di partecipazione alla lotta al nemico richiesto al cittadino-elettore è, appunto, quello del voto. Una volta eletto, è il leader che si assume l’incarico di costruire i muri (fisici, contro gli immigrati, doganali, contro i concorrenti, legislativi e giudiziari, contro i nemici interni).
Null’altro è richiesto.
Comodo, no?
Per questo (e per alcuni altri motivi che magari spiego in un altro momento) non sono d’accordo con chi invoca come chiave di lettura il fascismo eterno (ur-fascismo) di Umberto Eco. Se i suoi tratti costitutivi si possono ritrovare certamente nella cultura della destra europea e americana più che in quella di altre aree politiche, mi pare proprio servano a poco nello spiegarne il successo elettorale.
A me pare, invece, che il tutto si spieghi con il fatto che i messaggi (e, spesso, i leader) della destra appaiono più credibili nel proporsi come difensori e baluardi. In questo senso, davvero, non ho mai capito chi si domanda come una donna possa votare per Trump. Lo trova, semplicemente, una difesa più credibile. L’obiettivo è di soddisfare quella che Massimo Recalcati definirebbe “la tentazione del muro” (il titolo di un suo bellissimo saggio) e che io adatterei nella “esigenza del muro”. Lo stesso Recalcati, infatti, sottolinea:
Non bisogna dunque liquidare la spinta dell’uomo a difendere i confini della propria vita individuale e collettiva come una spinta in sé barbara o incivile. È un’indicazione che viene da Freud stesso: la vita individuale, come quella collettiva, necessita di protezione, di rassicurazione, edifica barriere per poter sopportare l’avversità del mondo. Gli esseri umani hanno da sempre protetto la loro esistenza; dalla potenza inumana della natura e dalla minaccia dei nemici. La spinta a delimitare il proprio territorio è un’espressione del carattere primariamente securitario della pulsione. Il gesto di tracciare il confine è un’operazione necessaria alla sopravvivenza della vita. La vita ricerca primordialmente il rifugio dalla vita e, al tempo stesso, la definizione di confini in grado di circoscrivere la propria identità.
[…] Senza radici e senza confini verrebbe infatti meno il sentimento stesso dell’identità di un soggetto individuale come di un soggetto collettivo, dell’Io come di un popolo. Non a caso nell’esperienza clinica l’assenza di confine definisce la vita schizofrenica: vita radicalmente smarrita, errabonda, disgregata, frammentata.
Tuttavia l’esistenza umana non è solamente desiderio di appartenenza e di rassicurazione, ma è anche spinta all’erranza, desiderio di libertà.
E da qui sviluppa proprio questa dinamica tra esigenza del confine e aspirazione alla libertà.
Rimangono, mi pare, due fatti.
Il primo: dal punto di vista della comunicazione politica, almeno in questo momento, soddisfare quella che Recalcati stesso definisce la pulsione securitaria sembra funzionare molto meglio di qualsiasi messaggio che faccia leva sull’aspirazione alla libertà.
Il secondo: declassare la pulsione securitaria a istinto ancestrale (ho letto di uomini del pleistocene…) non solo non funziona. Non è neppure giusto. Perché tracciare confini è un gesto che non è puro istinto: è definizione di identità individuale e collettiva.
La dico con le parole Alessandro Baricco:
L’idea di confine è una delle grandi conquiste degli umani sia dal punto di vista geopolitico (moltissime persone sono morte per difendere un confine, ancora mio nonno ha rischiato di morire per difendere un confine nel suo senso proprio più tecnico e più semplice, cioè il confine della sua patria e oggi lo fanno ancora in molti, nel mondo) ma è stata una conquista soprattutto psicologica. […] Mentre edifichiamo ponti, bisogna sempre ricordare che l’idea stessa di confine rappresenta per gli umani una conquista psicologica che è costata un sacco di tempo e un sacco di intelligenza. L’idea di confine, rassegnatevi, coincide con l’idea di identità. Senza confini è molto difficile avere un’identità.
(intervento alla quarta giornata interculturale Bicocca, maggio 2016)
Piuttosto, se si vuole costruire una contro-narrazione che abbia qualche speranza di fare breccia, bisogna ripensare profondamente questa dinamica tra confine e libertà.
Che non è come dirlo.
Conto, davvero, di approfondire.