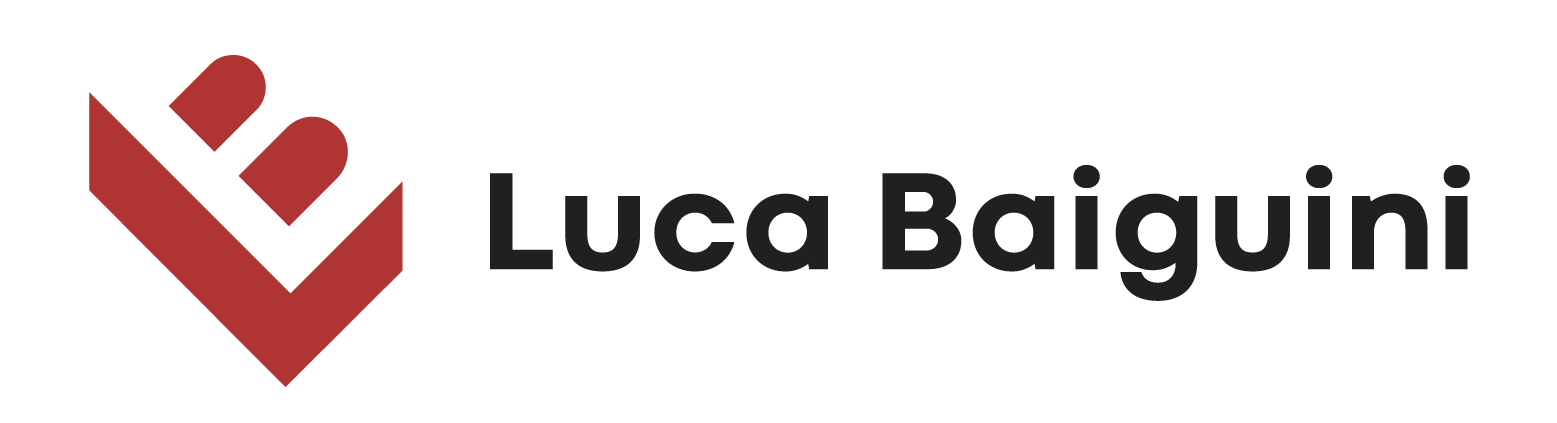Andrea Fontana sottolinea da giorni la necessità di una narrazione del dopo, quando, tra qualche mese, l’emergenza sarà finita.
Paolo Giordano e Luca Sofri, più modestamente, chiedono che qualcuno almeno pensi e racconti quale sarà il percorso che ci porterà verso il dopo, quello che intraprenderemo, auspicabilmente, tra qualche settimana.
Ho il sospetto che questi ultimi anni ci abbiano consegnato una classe politica incapace di comunicare il progetto, talmente accartocciata (come ho scritto tante volte qui) sul comunicare il nemico da aver perso i paradigmi fondamentali di come si costruisce una visione comune, di come si aggrega una collettività per qualcosa e non contro qualcuno.
Non mi piacciono le metafore e le similitudini belliche usate in questi giorni, descrivono in maniera molto parziale ciò che stiamo vivendo.
Il virus non è un avversario con una volontà e non ha, di per sé, neppure l’obiettivo di annientare l’organismo attaccato, la cui morte porta alla morte del virus stesso, per dire solo due differenze fondamentali.
Mi è piaciuto, anche se non mi trova sempre d’accordo nei contenuti, il tentativo fatto da Simone Perotti di mostrare un altro punto di vista, a partire dalla sua critica a #milanononsiferma, fino alla ricerca degli effetti collaterali positivi non solo come magra consolazione, ma come metodo d’indagine della realtà:
Insomma, effetti collaterali. Che sono sempre interessanti, sono il backstage della realtà. Ci raccontano sempre molto di noi, delle cose di cui ci danniamo, e forse delle nostre coscienze non sempre cristalline nel giudizio sulla vita.
Servirebbe, mi sembra, ora, ma soprattutto servirà dopo, una capacità di comunicare la complessità del nostro vivere e, in un certo senso, anche la sua fragilità.
Partendo da alcune cornici:
- chi spaccia soluzioni semplici, pozioni magiche infiocchettate con uno slogan, a problemi complessi o non ha idea di che cosa stia parlando o, più probabilmente, sta provando a fregarci;
- non esiste al mondo qualcuno che abbia tutte le risposte in tasca, né per questo né per gli altri problemi che saranno l’agenda dei prossimi anni (migrazioni, ambiente, stagnazione economica, dinamiche demografiche). Non sarà l’uomo forte, ma neppure quello intelligente. Sarà solo l’unione di pensieri e prospettive e la ricerca faticosa della sintesi, probabilmente fatta anche di errori inevitabili e della capacità di ammetterli. Questo dovrebbe essere il dibattito politico in una comunità sana;
- la fragilità è una componente ineliminabile del nostro esistere. Dovremo affrontare altre crisi, illudere del contrario non serve;
- ci sono cose che non stanno insieme, averle entrambe è impossibile, prometterle entrambe è disonesto. Si chiamano trade-off;
- la comunicazione politica deve, in qualche modo, contribuire anche a educare a tutto questo. Non può più accontentarsi di coagulare consenso.
Mi domando, però, se la vogliamo davvero una comunicazione così.
E se non siamo noi i primi a desiderarlo, l’uomo della provvidenza, quello che
- tranquilli, ci sono qua io
- non è colpa nostra
- non costa nulla
Quello che tranquilli, il nemico è lui, noi siamo i buoni.