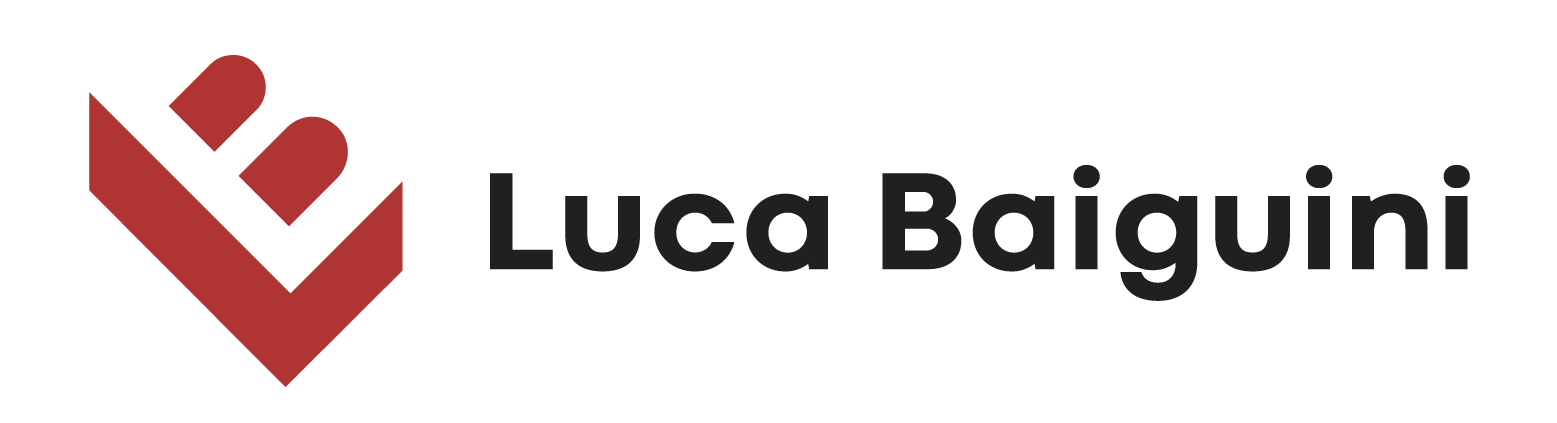F******g genius
Il 27 marzo si è spento Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia (primo psicologo a vincerlo) e vero e proprio gigante del pensiero di questi ultimi 50 anni. Di quelli sulle cui spalle è comodo appoggiarsi.
E, infatti, ci appoggiamo in tanti (una vera folla, a dirla tutta).
Le sue ricerche hanno contribuito a gettare un po’ di luce su come si muove quello strano animale grigio che ci portiamo nel mondo tra le orecchie, specialmente quando si tratta di decidere, ma non solo. E ci hanno mostrato come si muova in maniera bizzarra, anche se, in un certo senso, prevedibile.
Ne ha dette tante, bellissime, provocatorie.
Per questo lo citiamo tutti, anche a sproposito (succede a tutti questi cervelloni).
E io non mi sottraggo.
Voglio sottolineare due pezzi del suo pensiero: il problema delle pallottole d’argento e quello dell’overconfidence. E, poi, porre una questione
Pallottole d’argento
Per pallottole d’argento intendo quelle ricette semplici, fatte di pochi ingredienti e di “leggi” che promettono, se applicate, di portare a risultati straordinari, magari in pochissimo tempo.
È chiaro come un approccio di questo tipo ben risponda al bisogno di certezze e di appigli sicuri che, specie in tempi incerti, si manifesta tra chi, per lavoro, deve prendere decisioni.
Ecco che cosa ne pensa Kahnemar (copio da “Pensieri lenti e veloci“):
I consumatori sono affamati di messaggi chiari sui fattori che determinano il successo o il fallimento negli affari, e hanno bisogno di storie che diano loro l’impressione, per quanto illusoria, di averci capito qualcosa. […]
L’effetto alone e il bias del risultato si combinano per spiegare lo straordinario fascino esercitato dai libri che cercano di ricavare princìpi operativi dall’analisi sistematica di attività economiche di successo. […]
Le storie dell’ascesa e del crollo delle industrie toccano il cuore dei lettori, offrendo loro quello di cui ha bisogno la mente umana: un semplice messaggio di trionfo o fallimento, che identifichi cause chiare e ignori il potere determinante del caso e dell’inevitabile regressione verso la media. Questo tipo di storie induce e alimenta l’illusione della comprensione, impartendo lezioni di pochissimo valore ai lettori bramosi di crederci.
Overconfidence
Copio dall’articolo Don’t Blink! The Hazards of Confidence, scritto da Kahneman per il New York Times nel 2011:
La fiducia che sperimentiamo mentre formuliamo un giudizio non è una valutazione ragionata della probabilità che esso sia corretto. La fiducia è un sentimento, determinato principalmente dalla coerenza della narrazione e dalla facilità con cui viene alla mente, anche quando le prove a supporto della narrazione sono scarse e non affidabili. Il bias della coerenza favorisce l’overconfidence. Un individuo che esprime una fiducia elevata probabilmente ha una buona narrazione, che potrebbe essere vera o meno. […]
Spesso interagiamo con professionisti che esercitano il loro giudizio con evidente sicurezza, talvolta vantandosi del potere della loro intuizione. In un mondo pieno di illusioni di validità e capacità, possiamo fidarci di loro? […] Le persone inventano storie coerenti e fanno previsioni sicure anche quando sanno poco o nulla. L’overconfidence nasce perché le persone spesso sono cieche alla propria cecità. […]
La questione:
Quanti dei nostri libri, quanta della nostra formazione, quanti dei messaggi di quelli che fanno il nostro mestiere, in fondo in fondo, non fanno che alimentare questi due fenomeni?
Naturalmente, sempre citando Kahneman ogni volta che si può…
Post scriptum
E pensare che molti dicono che il vero genio fosse il suo collega e amico Amos Tversky, con cui Kahneman ha condiviso i primi, ruggenti, anni di ricerche e sperimentazioni. Malcolm Gladwell ha scritto che tra i suoi colleghi fosse molto popolare il Test di intelligenza che porta il suo nome: il test di intelligenza di Tversky, appunto. L’enunciato è, più o meno, questo:
Test di intelligenza di Tversky
Tu sei tanto più intelligente quanto meno tempo impieghi, in una conversazione con Tversky, ad accorgerti di essere meno intelligente di lui
per dire…
Adesso Daniel ha raggiunto il suo amico Amos. Immagino che, di là, ci sia una stanza in cui sta la gente così. Tutti insieme, a scambiarsi idee.
Sarebbe bello che, sulla porta, ci fosse scritto qualcosa come: F******g geniuses inside