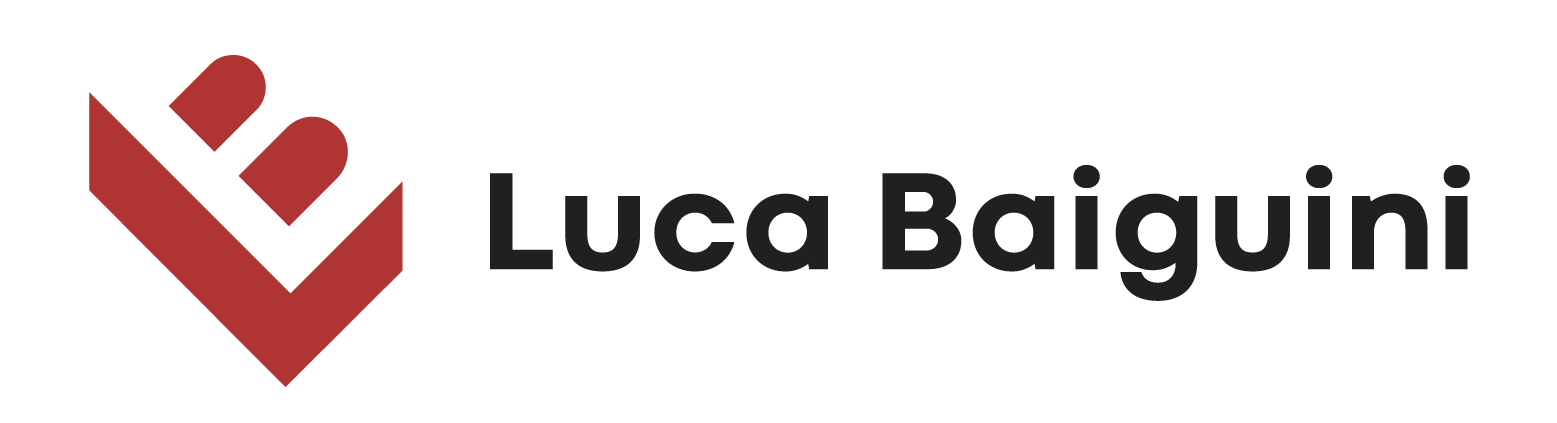In questo post per MySolutionPost ho parlato dei fenomeni che sono tra loro in relazione con curve ad U invertita.
Si tratta di quei fenomeni che, invece che essere in rapporto secondo andamenti lineari (al crescere di un fenomeno cresce proporzionalmente anche l’altro) o con andamenti con utilità marginale decrescente (al crescere di un fenomeno cresce anche l’altro, ma con un andamento sempre più piatto, fino a che la crescita marginale è praticamente nulla), sono in relazione tra loro con andamenti a U invertita (così, tanto per capirci: ∩)
In questo caso, la relazione tra le variabili è lineare fino ad un certo punto (al crescere della prima variabile cresce proporzionalmente la seconda), quindi la curva tende ad appiattirsi (rendimenti marginali decrescenti), fino a diventare completamente piatta (rendimenti marginali nulli), e, poi, addirittura negativa. Questo significa che, da un certo punto in avanti, la relazione si inverte e il crescere di una delle variabili porta ad una diminuzione della seconda.
In questi giorni (come succede in alcuni periodi dell’anno) sto viaggiando parecchio su e giù per l’Italia. Coincidenze fortunatamente non troppo strette o “buchi” nell’agenda mi permettono (meno di quanto mi piacerebbe) di godere di alcune delle bellezze dei luoghi che visito. Ogni volta mi trovo a considerare quanto il nostro Paese sia ricco di piccoli capolavori nascosti, di quanto ogni regione (anche le meno conosciute) potrebbe tranquillamente rivaleggiare con molte delle nazioni del mondo. E il pensiero successivo è, naturalmente, rivolto a quanto noi italiani non sappiamo far fruttare un patrimonio così vasto (detto che non credo a certe stime mirabolanti per cui l’Italia ospiterebbe quasi la metà del patrimonio artistico mondiale, ma questo è tutt’altro capitolo).
Mi è venuto da pensare, allora, che la relazione tra quantità di patrimonio artistico posseduto e “attrattività” di un luogo (o, come in questo caso, di una nazione) potrebbe essere una curva ad U invertita: fino a un certo punto le due variabili sono in una relazione positiva. Superato però un punto critico la relazione diventerebbe addirittura negativa. Detto in un altro modo, avere più patrimonio artistico è un vantaggio dal punto di vista dell’attrattività, ma solo fino a un certo punto. Oltrepassato quel punto diventa uno svantaggio.
Perché?
Mi vengono in mente alcuni motivi, ma potrebbero essercene altri:
1) conservare un patrimonio artistico e renderlo fruibile non è facile. È necessario investire risorse (denaro, ma non solo). Un patrimonio troppo rilevante potrebbe condurre a disperdere eccessivamente gli sforzi, e a non portare, alla fine, a casa nulla;
2) comunicare un patrimonio artistico implica, come ogni operazione di comunicazione, delle scelte e delle priorità. Un’eccessiva ricchezza di luoghi e capolavori non consente di fornire un’immagine unitaria alla proposta e, cercando di colpire troppi target, si finisce per non arrivare a nessuno;
3) un patrimonio disperso su territori diversi porta ad una sorta di “competizione interna”, che indebolisce nella competizione verso l’esterno. Molti territori in concorrenza tra loro non possono esprimere una strategia unitaria. I tentativi fatti negli ultimi anni in questo senso mi sono parsi piuttosto goffi.
Insomma, per noi che ci viviamo crescere immersi in tanta bellezza non può che essere una fortuna.
Forse, per altri obiettivi, sarebbe meglio se ce ne fosse un po’ meno…