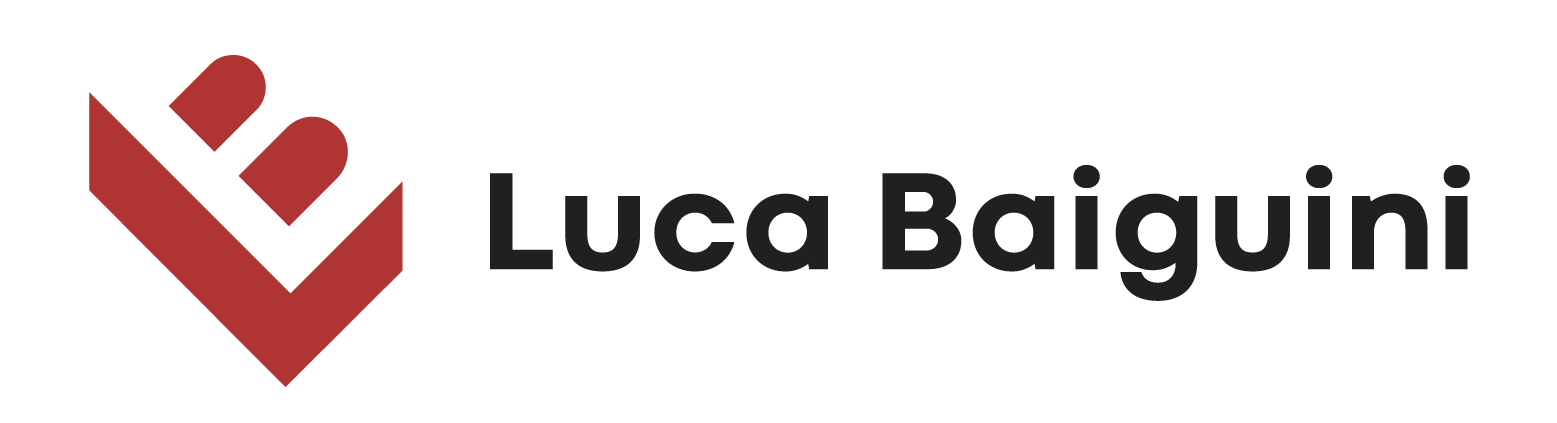Un’indagine
Un breve racconto: tre momenti e l’incrocio di tre vite.
Spero vi regali qualche minuto piacevole.
Per leggerlo potete scaricare il file, nel formato che preferite (nel dubbio, scaricate il .pdf), oppure scorrere direttamente il testo da questo post.
Come sempre, alla fine, lo spazio per commenti, se ce ne sono, e per critiche.
Un’indagine
 |
Scarica in formato .pdf (leggibile su quasi tutti i dispositivi) |
 |
Scarica in formato .mobi (leggibile su Amazon Kindle) |
 |
Scarica in formato .ePUB (leggibile sulla maggior parte degli e-book reader) |
Un’indagine
I
Agosto 2004
Don Gabriele,
le scrivo perché me ne vado. In cerca di fortuna, direbbe lei, con un tono che sottintende che la fortuna è vivere qui, e che la gratitudine suggerirebbe di rimanerci. In realtà, non cerco nulla. Ci sono partenze che sono fughe, Don Gabriele. Questo credo lo possa capire.
Ho voluto avvisarla per tempo, così che trovi il modo per insegnare a qualcun altro a portare la croce nella processione del venerdì santo. Non è per niente facile tenere su quei venti chili. Se lo ricorda quando mi ha detto che la croce, alla fine della quaresima, l’avrei portata io?
Passai ore ad allenare la forza e l’equilibrio: non volevo farmi cogliere di sorpresa dal peso del legno e da quello ancora più gravoso di essere chi sta davanti, in processione, e che quindi tutti lo vedono e lui non vede nessuno. Cominciai in chiesa, da solo. Alzare e abbassare: è da lì che si misura il portatore, se riesce in quei movimenti a conservare solennità, senza che il peso, il timore o la trascuratezza alterino la gradualità della partenza e la fermezza dell’arrivo. Poi, passata la prima fase di esercizio nascosto, uscii all’aperto: bisognava sentire il vento scuotere il legno e misurarne l’effetto sul drappo che copre la croce e che lei avrebbe levato pezzo a pezzo, durante le tappe della processione: Ecce lignum Crucis, in quo salus mundi pependit. Ecco il legno della croce da cui dipende la salvezza del mondo.
Uscii sul sagrato e il vento fece vibrare il legno tra le mie mani: mi parve di sentirlo riscaldarsi nel confronto che gli imponevo con la natura di cui era stato parte. Era chiara, in quel momento, la differenza tra il legno delle betulle che crescono sul sagrato e i due pezzi di larice che tenevo tra le mani, innestati a perpendicolo. Anche le betulle paiono opporsi al vento, ma in realtà sanno di essere parte del medesimo disegno. Non resistono, loro. Si lasciano aggirare: sanno che né loro né il vento decideranno quale sarà la raffica che, un giorno, le abbatterà.
Continua a leggere