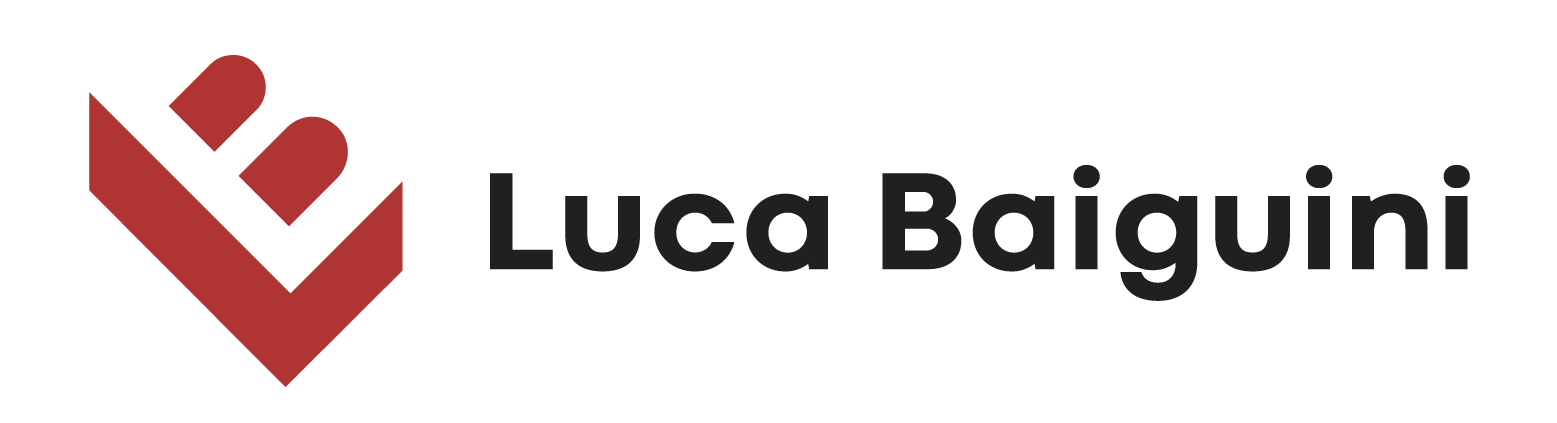Questo post sul blog di Alfonso Fuggetta mi ha ricordato l’importanza di quello che gli psicologi chiamano “Effetto Pigmalione“.
Questa locuzione fu introdotta in ambito psicologico da Robert Rosenthal.
Pigmalione, re di Cipro e leggendario scultore, realizzò una statua di donna talmente bella che se ne innamorò. Chiese quindi a Venere di concedergli una sposa altrettanto bella e la dea esaudì la sua richiesta animando la statua stessa.
Tornando a Rosenthal, egli sottopose ad un test di intelligenza gli alunni di una scuola elementare della California. Quindi, prese un campione casuale tra questi bambini e disse alle loro insegnanti che si trattava di bambini che, secondo il test, erano risultati particolarmente dotati.
Ad un anno di distanza quegli alunni si erano effettivamente dimostrati i migliori della classe.
E non si trattava soltanto di un giudizio dato dalle insegnanti, i ragazzini in questione erano migliorati in modo sorprendente.
La spiegazione di quello che Rosenthal ha chiamato, appunto, effetto Pigmalione, è che le nostre aspettative possono influenzare in maniera radicale le nostre relazioni e le performance che possiamo ottenere dagli altri. Le insegnanti, credendo nell’alto potenziale di quei bambini, si comportarono con loro in modo diverso rispetto a quanto avrebbero fatto normalmente (più incoraggiamento, più stimoli…). E i bambini reagirono di conseguenza, ottenendo risultati migliori.
Il comportamento delle maestre aveva consentito ai bambini di mettere in campo il meglio delle loro capacità.
L’effetto Pigmalione influenza i rapporti umani, di qualunque natura essi siano, e purtroppo non sempre in maniera positiva.
E’ quella che Watzlawick chiamerebbe una “profezia che si autorealizza”.
Questo può spiegare anche perché alcune persone sembrano particolarmente sfortunate nei rapporti con gli altri: incontrano colleghi ipocriti, amici inaffidabili, partner egoisti, eccetera eccetera.
In realtà, vengono trattati come si aspettano di esserlo.
Chi si aspetta di essere tradito, mette in campo una serie di strategie che portano la dinamica relazionale proprio nella direzione che si vorrebbe evitare. In questo senso, la “profezia” del tradimento si “autorealizza”.
Per approfondire: