Guerre di trincea
Ieri si parlava con un caro amico di quelle situazioni in cui i processi di comunicazione o di problem solving finiscono in una situazione di stallo, ed il perpetuarsi di schemi poco funzionali non fa che peggiorare questo avvitamento.
Mi ha ricordato la guerra di trincea.
E mi ha ricordato un passaggio di “Questa storia”, di Alessandro Baricco, in cui quella cosa là (la guerra di trincea, intendo) viene descritta con il modo di scrivere di Baricco, che tu lo leggi e lui ti ha spiegato un pezzo di mondo.
Descrive, qui, come i tedeschi sfondarono le linee nel ’17, nell’attacco che porterà a Caporetto.
“Così lui assunse un tono più mite – ancora lo ricordo – enunciandomi le due leggi che ogni manovra d’attacco doveva rispettare, secondo i manuali di guerra. La prima era vecchia come l’arte del combattere e decretava che per vincere bisognava conquistare le vette, i punti da cui si poteva dominare il terreno. Più che un principio stratetico era una categoria mentale, mille volte riaffermata dalle roccaforti che in ogni parte del mondo sancivano l’ubicazione del potere collocandolo in alto, dove qualsiasi movimento umano risultava sotto controllo. La seconda regola, innegabilmente logica, indicava la necessità di avanzare con uno schieramento compatto, conservando una linea di fronte il più ampia possibile, così da non rischiare di perdere in avanti singole porzioni di truppa, destinate a scollarsi dal grosso dell’esercito e a trovarsi prima isolate dai rifornimenti e poi, inesorabilmente, accerchiate. Da un punto di vista geometrico, un ragionamento ineccepibile. Si trattava di regole che i tedeschi conoscevano benissimo. Si può dire che avessero contribuito attivamente a fondarle. Attaccarono, il 24 ottobre 1917, affidandosi a una strategia che potrebbe essere così riassunta: date le regole, fare il contrario. Incuranti delle vette, avanzarono nel fondovalle, dove le difese erano più morbide e disattente. E lo fecero con piccoli reparti d’assalto, a cui era stato dato l’ordine, impensabile, di affondare nelle linee nemiche e di non fermarsi mai, perdendo qualsiasi contatto col grosso dell’esercito e decidendo autonomamente i propri spostamenti e le proprie azioni. L’idea era quella di penetrare nelle linee nemiche come termiti che, scelta la via d’accesso dove il legno era più morbido, avrebbero poi scavato nelle interiora dello schieramento nemico fino a che le vette, neppure conquistate, sarebbero crollate da sole. Fu esattamente quello che successe.
Ed ecco l’effetto di questa strategia
[…] e nessuno può capire cosa successe quando quell’ufficiale tedesco, con una rivoltella in mano, sbucò dalle nubi, alle nostre spalle, salito dal fondovalle con quattro o cinque uomini armati, e iniziò ad urlare in italiano di arrenderci, senza la minima esitazione, perfino con calma, come annotando il risultato ovvio di una operazione banale. Vedete come da un punto di vista squisitamente militare – avrebbe concesso il capitano con i suoi trant’anni da salvare – la situazione fosse molto chiara, essendo noi 278 e loro quattro o cinque, ma è la geometria delle menti e delle anime che va qui compresa – avrebbe obbiettato il capitano, cogliendo in effetti nel segno e forse sfiorando il mistero di quelo che successe a Caporetto. Perché erano animali addestrati a un tipo di guerra molto particolare, in cui l’avere il nemico di fronte era l’unica geometria conosciuta: l’aver speso tanto tempo e indicibili sofferenze in quell’unica figura aveva ottenuto di elevarla a forma dell’essere, a schema immutabile della percezione. Ciò che accadeva lo faceva nelle forme a priori di quella geometria, e quando ricevevano la morte essa arrivava dalla trincea di fronte, e quando portavano la morte, la portavano dritti davanti a sé, alla trincea che li aspettava. All’interno di quello schema ferreo avevano maturato un sapere raffinatissimo e un’indicibile disponibilità al sacrificio: ma quanto più in loro si coagulava l’intimità con quell’unico movimento preciso, tanto più sfumava la memoria delle infinite possibilità dello spazio e svaniva la capacità, anche morale, a sostenere l’anomalia di un movimento che non fosse quello frontale. Per questo l’ipotesi di trovarsi attaccati alle spalle aveva cessato di figurare nel loro indice dell’immaginabile, e quando effettivamente divenne realtà, nell’irreale cornice di un isolamento totale, dovette parere loro non tanto come una situazione di combattimento da interpretare, quanto piuttosto come una magica sospensione del combattimento stesso, un decadere improvviso del tutto, che li sollevava dal compito di reagire. […]
Usando la trincea come metafora (con tutto il rispetto per chi l’ha vissuta davvero e che, forse, di metafore non ne vorrebbe sentir parlare), potrebbe essere interessante farsi alcune domande.
Quanto spesso succede che l’aver speso tanto tempo e indicibili sofferenze in un’unica figura, strategia, processo comunicativo ottiene come effetto collaterale quello di elevarli a forme dell’essere, a schemi immutabili della percezione, sfumando ogni altra possibilità?
Quando questi principi stategici diventano delle inattaccabili categorie mentali?
Che ruolo ha l’essersi costruiti, all’interno di questi confini, “un sapere raffinatissimo e un’indicibile disponibilità al sacrificio”?
E se, come i tedeschi, di fronte a una guerra di trincea, qualcuno avesse il coraggio di dire “Date le regole, fare il contrario”?
Certo, questo coraggio implica due abilità non banali: quella di saper osservare i processi da un punto di vista che ne comprenda a fondo le dinamiche.
E quella di saper generare delle dinamiche alternative.
Credo che la formazione manageriale, ridotta ai minimi termini, debba porsi l’obiettivo di generare queste due capacità.
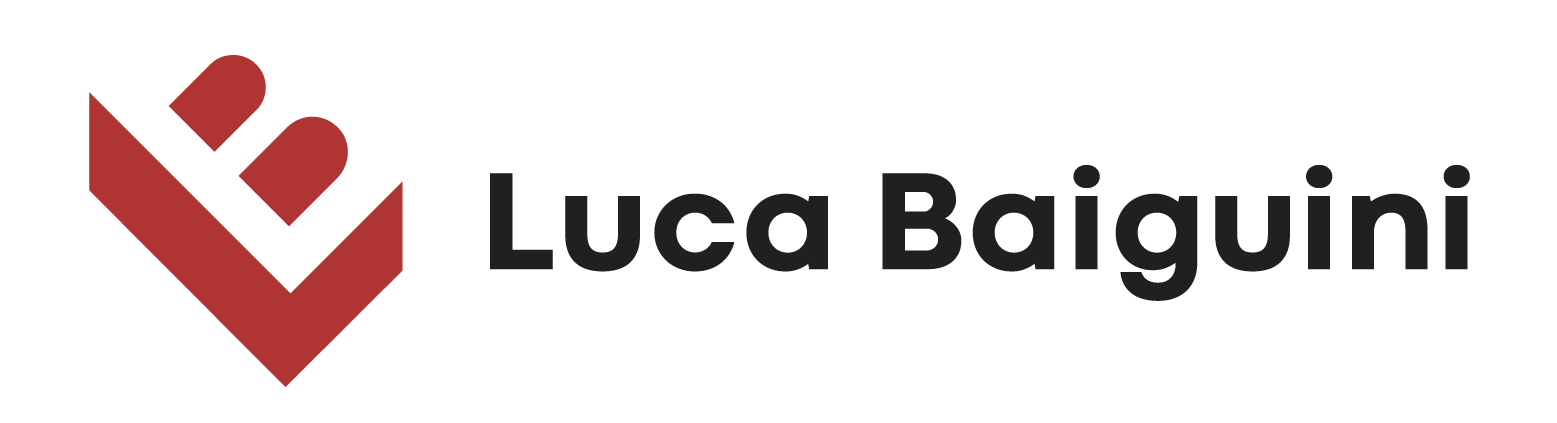
credo di non aver compreso a fondo tutto il tuo messaggio. quello su cui vorrei soffermarmi, è le due abilità, e il fatto di ragionare e creare soluzioni non precostituite e alternative ai problemi che via via si presentano. neanche a farlo apposta, ieri ho scritto, su un foglietto volante, una cosa che dice "le regole servono all’uomo o l’uomo serve alle regole ? insomma invito a ragionare su dei comportamenti, apparentemente banali, che molti hanno, tipo non lasciar passare un’autoambulanza con la sirena accesa, ma ce ne sono tanti altri. Perché si agisce per schemi, anche sul lavoro per adempimenti ? d’altra parte pensare soluzioni diverse per ogni problema è più efficace, si, ma richiede creatività, impegno, costanza, volontà, collaborazione, passione, altre cose che non mi ricordo, comunque fatica! Sinceramente, ditemi quanti ne conoscete così !
E’ vero, soluzioni non convenzionali richiedono molte delle doti di cui hai parlato. La metafora della Guerra di trincea vuole essere anche un’indicazione di quando è necessario e (forse) più produttivo essere in grado di pensare in maniera non convenzionale: in tutte quelle situazioni in cui la semplice reazione stimolo-risposta, secondo schemi stabiliti, non porta più da nessuna parte.