Teorie forti
Su “La terapia dell’azienda malata” leggo di un esperimento interessante condotto da Bavelas all’Università di Stanford. L’indagine è stata condotta su soggetti di età, sesso, condizione sociale diversa. A ciascuno di loro è stata data questa istruzione:
“Io adesso leggerò un certo numero di coppie di cifre a due a due, lei dovrà dirmi se queste cifre si accordano o meno tra di loro“.
Naturalmente, i soggetti chiedevano di specificare meglio che cosa significasse “accordarsi”. Lo sperimentatore rispondeva, allora, che l’esperimento consisteva proprio nello scoprire la natura dei nessi. Si trattava, quindi, di procedere per tentativi ed errori fino ad arrivare a trovare il nesso logico corretto.
Traggo la descrizione dell’esperimento direttamente dal libro citato:
All’inizio lo sperimentatore dichiarava sempre sbagliate le risposte del soggetto, poi – senza seguire alcuna logica – cominciava a dichiarare che alcune erano giuste. Continuava, in seguito, sempre casualmente – ovvero senza alcuna valutazione effettiva della risposta – aumentando il numero di risposte definite come corrette. L’esperimento procedeva facendo in modo che il soggetto avesse l’impressione di incrementare progressivamente la correttezza delle sue risposte. Quando si giungeva al punto in cui lo sperimentatore dichiarava sempre corrette le risposte del soggetto, lo psicologo interrompeva l’esperimento e chiedeva al soggetto di spiegargli come si fosse formato nella mente i modelli logici che lo avevano portato a procedere nell’esperimento e a stabilire un nesso fra le cifre proposte. Le spiegazioni offerte erano solitamente complicatissime, talvolta decisamente astruse. A quel punto, lo sperimentatore svelava il trucco dell’esperimento e confessava al soggetto che non esisteva alcun nesso logico che legava i numeri, e che aveva dichiarato giuste o sbagliate le risposte su uno schema preordinato. Non esisteva dunque alcuna reale corrispondenza tra le domande e le risposte, alcun nesso matematico, logico, figurativo, ecc.
Quello che appare particolarmente interessante è che, a questo punto, la stragrande maggioranza dei soggetti si rifiutava di credere allo psicologo e manifestava una gradissima difficoltà ad abbandonare la visione che aveva costruito con la propria mente. Alcuni soggetti, addirittura, cercavano di convincere lo sperimentatore che esistevano davvero dei nessi logici dei quali lui non si era ancora reso conto.
Questo esperimento, come molti altri dello stesso tipo, dimostra chiaramente come le persone presentino grandi difficoltà a modificare una propria convinzione, dopo che questa è venuta costruendosi mediante un processo esperienziale vissuto come efficace e si sia strutturata come teoria di riferimento del soggetto.
Mi pare una provocazione davvero stimolante.
Credo mi sia successo molte volte di innamorarmi di un modello di problem solving, di una teoria manageriale o comportamentale tanto da farne una “Teoria forte”, alla quale adattare le informazioni che giungono dalla realtà.
Cito Albert Einstein:
“Sono le teorie che determinano ciò che possiamo osservare”
e anche, scherzosamente ma non troppo
“Se i fatti e la teoria non concordano, cambia i fatti”
Dettagli sulla fonte: La terapia dell’azienda malata, di G.Nardone, R.Mariotti, R.Milanese, A.Fiorenza – Ponte alle Grazie, Novembre 2000
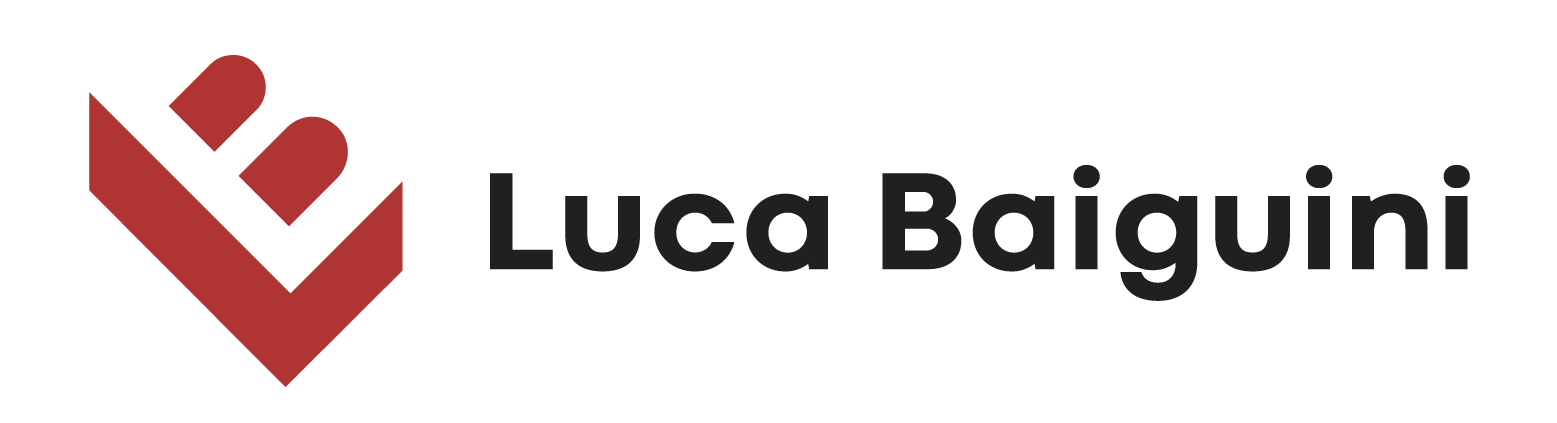
Le nostre convinzioni, le nostre certezze. vuoi dire che non sono mai assolute ? che tutto dovrebbe essere provvisorio ?. alcune certezze di base ce l’ho. anche se ho constatato più volte che non esistono regole comportamentali assolute ed ogni caso è a se, bisogna sempre "riadattarsi", partendo da quelle certezze e dandosi un metodo. Luca è parecchio tempo che non riesco da casa a lasciarti un commento e mi piacerebbe che anche tu mi dicessi, una volta, cosa ne pensi di qualche mio post. ti aspetto. Silvia earth kataweb ciao Silvia
Ciao Silvia.Credo che la provocazione sia in questi termini: una volta che adottiamo una teoria forte, quanto spesso ci succede di "adattare" i fatti a questa teoria? Di perdere, quindi, lucidità nella lettura di ciò che ci avviene attorno?
più semplicemente:non accettare che ci siamo fatti prendere in giro,teorizzando un momento di stupidità in un momento di ragionamento sul niente.Penso che la causa sia dovuta alla mancanza di autoironia,o peggio di narcisismo.
P.S.Anch’io gradirei una tua critica,anche feroce,su qualche mio commento.
Come sempre ,sentiti saluti.
Ciao
Sì, l’effetto “presa in giro” potrebbe influire su un esperimento di questo tipo. Il problema mi sembra però più profondo: ha a che vedere con il confirmation bias, ossia con la tendenza a filtrare le informazioni privilegiando quelle che confermano piuttosto che disconfermare le nostre convinzioni. Qualcosa di più, qui:
https://www.lucabaiguini.com/2007/09/confirmation-bias.html
Un saluto a te, Angelo.