Ci si inchina solo alle domande
Ho iniziato la lettura del libro di Umberto Santucci "Fai luce sulla chiave. Problem setting: l’arte di definire i problemi prima di risolverli".
La prefazione, di Dario Simoncini e Mariella De Simone, inizia con una storia tratta da C’è nessuno? di Jostein Gaardner.
Eccola:
«Puoi mangiare una mela» dissi porgendogli il frutto.
Sembrava che non ne avesse mai viste in vita sua: per un po’ rimase incantato ad annusarla, poi si fece coraggio e le diede un morsettino.
«Gnam, gnam» disse con la bocca piena.
«È buona?» domandai.
Lui fece un profondo inchino.
Volevo sapere che gusto avesse una mela quando la si assaggiava per la prima volta, e insistei:
«Ti è piaciuta?»
Mika si inchinò a ripetizione. «Perché fai l’inchino?» domandai. Si inchinò di nuovo. Sbigottito da quel profluvio di cortesia, gli chiesi ancora una volta:
«Perché fai l’inchino?»
Ora fu lui a rimanere sbalordito. Credo non sapesse se doveva fare un altro inchino oppure limitarsi a rispondere.
«Nel posto da cui vengo ci inchiniamo sempre quando qualcuno fa una domanda acuta» spiegò. «E più profonda è la domanda, più profondo è l’inchino».
Non avevo mai sentito una cosa tanto strana: non riuscivo a capacitarmi che una domanda potesse meritare un inchino.
«E allora quando dovete salutarvi cosa fate?»
«Cerchiamo di escogitare qualcosa di intelligente da domandare» rispose.
«E perché?»
Fece un rapido inchino dato che gli avevo rivolto un’altra domanda, poi spiegò:
«Cerchiamo di pensare qualcosa di intelligente da domandare in modo da far inchinare l’altro».
Fui talmente colpito da quella risposta che, quasi senza volerlo, mi inchinai profondamente. Quando alzai lo sguardo, Mika si era infilato il pollice in bocca. Se lo tolse solo dopo un bel po’.
«Perché hai fatto l’inchino?» mi chiese allora quasi offeso.
«Perché hai risposto in modo molto intelligente alla mia domanda» spiegai.
Allora Mika con voce limpida e chiara scandì alcune parole che non ho mai più dimenticato:
«Una risposta non merita mai un inchino: per quanto intelligente e giusta ci possa sembrare, non dobbiamo mai inchinarci a una risposta».
Annuii con un cenno della testa, pentendomi immediatamente perché Mika poteva pensare che mi ero inchinato alla sua risposta.
«Chi si inchina si piega» continuò Mika. «Non devi mai piegarti davanti a una risposta».
«E perché no?»
«Una risposta è il tratto di strada che ti sei lasciato alle spalle. Solo una domanda può puntare oltre».
Devo ricordarmi, mentre progetto il prossimo percorso formativo, di cercare qualcosa di intelligente da domandare, piuttosto che qualche risposta intelligente da dare.
E, magari, cercherò anche di ricordare che questo blog dovrebbe essere un luogo di domande più che di risposte.
Per puntare oltre il tratto di strada che mi sono lasciato alle spalle.
Ci sono domande?
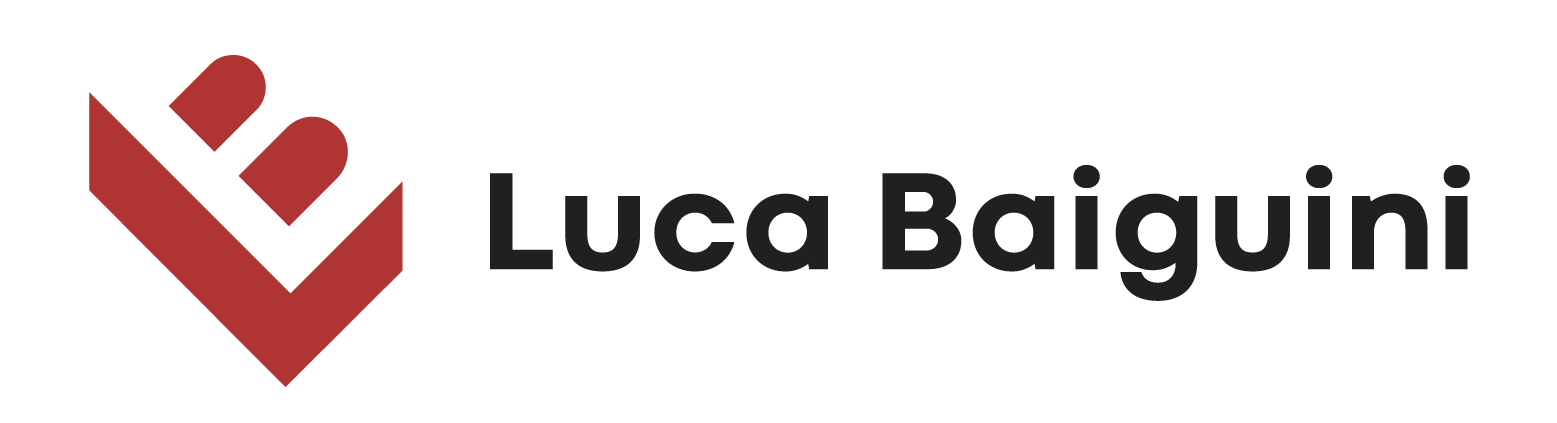
"Non ci sono domande stupide, ci sono solo risposte stupide"Questo l’ho sentito dire da Federico Capasso in un seminario che tenne al Politecnico di Milano tanti anni fa…
Sì, io ho una domanda.Perché molti docenti non riescono a scendere dalla cattedra e mettono tra loro e gli allievi tanta, ma tanta, distanza, come se avessero paura delle domande?Forse perché non sono sicuri delle risposte?Forse perché hanno paura che ad una domanda cui si risponde, poi possono fare seguito tante altre domande?Mi è molto piaciuto questo post e concordo appieno.Un giorno una ragazza in stage, lei aveva 19 anni ed io ero responsabile sviluppo PC, mi guardò e timidamente mi disse: "Frà, io forse non ho capito, ma mi pare che manchi un campo in questo record. Mi spieghi dov’è o qual’è, che mi serve?"Lei era timida e non osava dire al suo capo che mancava qualcosa, così invece mi fece una domanda su una cosa che non le era chiara. Invece aveva ragione lei, il campo mancava e lei se ne era accorta solo leggendo l’analisi, senza ancora essere neppure entrata nel tema.Un minuto dopo andai in Direzione e la feci assumere all’istante (poi l’assumettero invece qualche giorno dopo, per le solite questioni burocratiche).La ragazza si chiamava Elena Vitali, lo ricordo come fosse oggi, anche se da allora sono passati venti anni e forse più. Lei non seppe mai a cosa fu dovuta la sua assunzione.
Bellissimo davvero…. oggi purtroppo si è troppo tesi a dare le risposte, a cercarle, a metterci come dice fradefra in cattedra, a volte anche quando non si è docenti…. non ci si interroga, non ci si fa domande, non le si rivolge agli altri, tempo perso? No, occasioni per crescere.Ciao Luca 🙂
Troppo bella. T’ho appena citato sul nostro blog 🙂
Ciao Luca!grazie al post di francesco sono venuto a conoscenza di questo blog e ti assicuro che hai colpito nel segno…una cosa che ho sempre criticato nelle persone che hanno tentato di insegnarmi come funziona la comunicazione… incapacità totale di comunicare con la paura di rispondere, nonchè il pensiero di essere infallibili.PS: ti sei appena guadagnato un lettore… 🙂
Ecco, Luca, mo ti tocca pagarci la provvigione :p
Francesco, fai per due… ho scoperto il post dal vostro blog!Bel post, mi ha fatto scoprire un ulteriore punto di vista, tra l’altro interessante e stimolante.
Grazie a tutti per i commenti, e benvenuti!Dal punto di vista del docente, credo ci siano due modi di fare formazione:- uno è quello di fare di tutto per "scaricare" sugli altri la conoscenza del docente- l’altro è quello di creare uno "spazio di pensabilità" rispetto ai temi trattati, nel quale costruire una conoscenza socializzata.Nel caso della formazione comportamentale, di cui mi occupo io, se si agisce nel primo modo si è matematicamente certi di generare resistenze che poi è difficilissimo vincere. Non ho esperienza, invece, di formazione tecnica.Come funziona? (sicuramente fradefra ne sa più di me).@fradefra: presumo di poter pagare il debito in generi alimentari tipici… 😉
Scusate per il ritardo della mia risposta, ma solo rileggendo dopo parecchio tempo l’ultimo commento di Luca, mi accorgo che mi aveva fatto una domanda.
In effetti nella formazione tecnica sicuramente ci sono alcune differenze. Ad esempio, le esercitazioni. La vera formazione tecnica che pretenda un minimo di autonomia acquisita da chi frequenta un corso, implica la possibilità di fare un esercizio, qualche prova, ecc. ecc. Diversamente, si tratta solo di nozionismo, cosa che può essere importante, ma ovviamente è cosa diversa.
Quando mi occupavo di formazione preminentemente tecnica, analisi, progettazione, programmazione, amministrazione di reti e database, ovviamente si ha un flusso Docente –> Allievo decisamente alto. L’allievo viene in aula principalmente per sentirsi dire, raccontare, quasi investire. Potrebbe a volte restarci male, se avesse la sensazione che invece qualcuno sta chiedendo a lui (a torto o ragione, non importa).
In questi corsi mi sforzavo sempre di sviluppare l’interazione, preoccupandomi sempre che ci fosse una chiara sensazione di spostamento di conoscenza Docente / Allievo molto alta, nel verso giusto. Sbagliando questa parte, anche a fronte di ottima formazione, gli allievi restavano scontenti.
Premetto che non mi occupo più di formazione tecnica da quasi dieci anni, quindi non so come siano i nuovi allievi/tecnici e cosa si aspettino. Magari un giorno vado a seguire un corso anche io 🙂
Il commento di fradefra mi ricorda il processo di apprendimento che mi capita spesso di raccontare in aula, che avviene in quattro fasi:
1. Incompetenza inconsapevole: non si sa fare, e non ci si pone nemmeno il problema di acquisire un’abilità perché non se ne conoscono l’esistenza e/o l’utilità.
Per esempio, un abitante di un villaggio sperduto dell’Amazzonia con tutta probabilità non sa guidare un’automobile, e nemmeno si pone il problema di imparare, visto che non sa che cosa sia un’automobile.
2. Incompetenza consapevole: non si sa fare, ma si riconosce la necessità, o quantomeno l’utilità, di imparare un’abilità.
Non si è in grado di guidare un’automobile, ma si sa che l’automobile esiste e si ritiene utile o necessario imparare.
3. Competenza consapevole: si sa fare, ma soltanto in maniera cosciente e prestando attenzione al processo.
È la condizione del principiante, che deve “pensare” a ciò che sta facendo per riuscire a guidare, ed è completamente assorbito dal processo di guida
4. Competenza inconsapevole: si sa fare, ed il saper fare è ormai un automatismo che non richiede particolare concentrazione
Il guidatore provetto riesce a guidare e contemporaneamente è in grado di fare altre cose, perché la sua attenzione non è completamente concentrata sul processo di guida.
In questo senso, le esercitazioni (ma anche l’interazione con il docente) anche in una formazione di carattere tecnico devono avere l’obiettivo di facilitare il percorso attraverso queste fasi.
ti ringrazio sinceramente e sono davvero costretto a rubartela la storiella per raccontarla al prossimo workshop. Sono certo dell’utilità di porsi le domande giuste, soprattutto in un percorso di miglioramento personale, pittosto di fossilizzarsi su risposte destinate ad invecchiare in un mondo in continua evoluzione.
Sono d’accordo, più la realtà è fluida e più le domande diventano importanti!
“Già non attendere’ io tua dimanda,
s’io m’intuassi, come tu t’inmii”
Dante, Paradiso, IX, versi 80-81.
Grazie mille, Luca. Attingerò a questa storia in una delle prossime lezioni. Sette secoli fa, durante un viaggio diventato poi famoso, ci si era già interrogati sulle domande. L’unico modo per precederle è saltare nella testa degli interlocutori, creare intimità, realizzare la vera (vera!) em-pathia. Ossia – più poeticamente – diventare i nostri stessi interlocutori come essi diventano noi. A quel punto la domanda non si attenderà. Ma probabilmente, in ossequio agli inchini, verrà comunque posta. “Intuarmi” con il prossimo come il prossimo si “immia” in me. Bella sfida…
Perché davanti alle domande prevale la fretta di dare risposte, senza darsi il tempo di ascoltarle davvero?
Intendo dire lasciare spazio a quel tanto di punto di vista differente che la domanda presuppone?
Perché così frequentemente ci difendiamo dalle domande?
Perché nel cercare risposte ci concentriamo più sulla possibilità di trovare risposte nella nostra ottica, piuttosto che ac-cogliere lo sguardo differente?
Mi pare che ciò avvenga sia nelle situazioni di apprendimento (scuole e formazione)che nella vita quotidiana.
La storia citata da Luca mi fa riflettere sulle dinamiche della comunicazione e soprattutto sull’importanza e la necessità dell’ascolto che l’accoglienza delle domande presuppone, soprattutto quelle che maggiormente spiazzano.
In fondo creare una situazione di interazione in cui le domande sono stimolate e valorizzate non è come creare spazio alla infinita possibilità delle differenze? Allargare gli orizzonti per tutti?
grazie a Luca per questa riflessione e bellissima la citazione di Dante
Grazie Giulia, bellissimo commento.
Mi capita spesso di citare questa storia anche per dire che c’è una forma di esercizio della leadership che ha a che vedere più con la creazione di un ambiente in cui “ci si inchina alle domande” piuttosto che un ambiente in cui l’aspettativa è quella di ottenere sempre e comunque risposte.
abbiate l’affetto di leggermi:
se un docente, nel 2000, afferma che Malta fa parte dell’Italia, o che gli Egiziani hanno costruito le piramidi, o che una determinata operazione matematica fa “all’incirca” così, il docente è un incompetente consapevole oppure un incompetente consapevole?
Quale formazione può così dare un docente a studenti universitari che seguono “scienza della formazione”?
Senza ombra di polemica “politica” o di controllo dell’insegnamento. Solo l’amore per un obiettivo trasferimento dei dati: mia figlia, domani,sarà, spero, l’insegnante dei Vostri figli o nipoti: e se, magari, non avesse dei genitori che l’aiutano a “rettificare” questi “lapsus”, che faremo?
Con apprensione e molte preoccupazioni …
Cosa ne pensate, Luca e amici?
Grazie Michele per il commento.
Credo dobbiamo partire da un presupposto: che fare buone domande richiede almeno altrettanta preparazione, e rigore, e (diciamolo) sacrificio che dare buone risposte. E poi, presuppone la capacità di ascoltare e trarre il meglio dalle risposte, specie se si parla di educazione.
Ne parlo, in un certo senso, qui:
https://www.lucabaiguini.com/2010/09/modelli-christiansen.html