Tesi, antitesi, sintesi
I commenti all’articolo sul brainstorming mi hanno portato a riflettere, in questi giorni, su un aspetto collaterale (ma forse non poi tanto) che ha a che vedere con la valutazione di un’idea o di un progetto, e con i relativi processi di decision making.
Normalmente un singolo o un team che valutano un’idea o un progetto cercano di ponderarne punti di forza e punti deboli, opportunità e minacce (nell’analisi SWOT, ad esempio), vantaggi e svantaggi, costi e opportunità nella maniera più equanime possibile.
Il presupposto è che ciascuno assuma una posizione obiettiva, onesta, equidistante.
Nel caso di una valutazione effettuata da un team, la somma di queste equidistanze dovrebbe portare alla decisione migliore.
Questo è un modo di procedere.
Ne esiste, però, un altro, che ha una lunga tradizione nella storia del pensiero e, come vedremo, larga applicazione.
Si tratta del metodo basato su tesi, antitesi, sintesi.
È su questo principio che poggiano, ad esempio, i dialoghi platonici.
Ed è sullo stesso principio che si basa la procedura penale o civile: due tesi contrapposte da cui ci si attende emerga una sintesi che porti alla verità dei fatti.
Hegel ha eletto questo processo a principio di realtà: non è soltanto il processo comunicativo che funziona per tesi, antitesi e sintesi, ma l’evoluzione della realtà stessa si fonda su questa dinamica.
C’è un presupposto interessante, ben visibile nelle aule dei tribunali: dalle due parti non ci si attende equanimità e obiettività.
Il “gioco delle parti”, anzi, si basa proprio sulla parzialità delle tesi contrapposte.
Nessuno si attende dall’avvocato dell’accusa equilibrio nella valutazione degli elementi di prova. Piuttosto, ci si aspetta grande abilità nel “tirare l’acqua al proprio mulino“.
Il principio che anima questa aspettativa è semplice: otterrò un risultato migliore dalla contrapposizione di due parzialità dichiarate rispetto alla somma di più imparzialità.
Due fazioni ciascuna delle quali espone le proprie ragioni parziali con la forza generata proprio da questa parzialità porteranno a sviscerare la realtà in modo così approfondito da generare una sintesi efficace. La sintesi, poi, potrà essere generata dalle parti a seguito della discussione, oppure da un terzo che abbia raccolto le ragioni della tesi e dell’antitesi.
Mi domando se questo principio possa trovare una qualche applicazione pratica nei processi di decision making nelle organizzazioni…
Che ne pensate? (Naturalmente, dividetevi in due fazioni per nulla equanimi!)
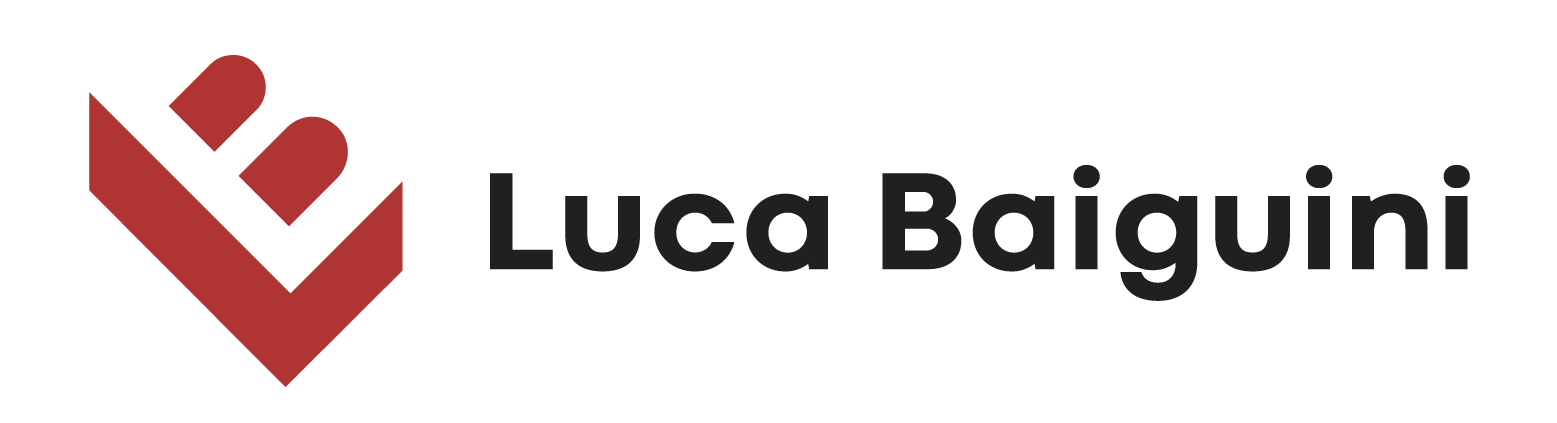
E’ un metodo che spesso utilizziamo. Mi chiedo quanto possa essere utilizzato anche dal singolo o da piccoli gruppi omogenei cercando di porsi in posizioni in antitesi con quella iniziale …
Credo, di primo acchito, che la difficoltà più grossa stia nel riuscire, a fine processo, a staccare i partecipanti dalla loro visione “parziale” ed a fare adottare la visione di sintesi…