Modelli, complessità e vulgata
Ho ascoltato, in questi giorni, alcuni degli interventi dello scorso Festival dell’Economia di Trento.
Alcuni mi hanno interessato particolarmente. Uno di questi è un intervento di Luigi Spaventa in una sessione chiamata “Processo ai controllori e ai politici”.
Il format era quello di un vero e proprio processo, con un’accusa ed una difesa. Spaventa rappresentava l’accusa, appunto, ai contollori e ai politici, che poco o nulla avrebbero fatto per prevenire la crisi.
Voglio sottolineare, in particolare, un passaggio che riguarda, più che le autorità politiche e di controllo, gli economisti, perché mi sembra vi si esprima un concetto interessante.
Ecco che cosa dice Spaventa verso la fine del suo J’accuse:
“Ormai si legge ovunque che l’approccio della supervisione si basava su premesse fallaci: mercati in grado di autocorreggersi, capacità e interesse del management a evitare i rischi, vantaggi di uno sviluppo senza ostacoli dei mercati finanziari, dunque, come ha scritto Henry Kaufman, l’accettazione da parte della FED di un libertarian dogma.
Allora, mi chiedo, qual era la fonte di questa diffusa saggezza convenzionale recepita da Banca Centrale e regolatori (la quale saggezza convenzionale coincideva, si dà il caso, con gli interessi dei regolati)?
In realtà questo fa parte di uno Zeitgeist, di uno spirito del tempo, il quale era lo spirito del tempo della grande moderazione, di quegli anni d’oro in cui tutto andava bene, un sentimento di fine della storia economica, un Fukujama con immediati effetti, con il macroeconomista come ingegnere, come scrisse Greg Mankiw.
Ieri furono processati gli economisti, oggi me ne dovrò occupare da un altro versante. Non il versante deplorevole dove l’ideologia viene motivata con la scienza e la scienza si corrompe in ideologia, che pure è frequentissimo. Neppure quello assolutorio, che in parte era quello di Perotti ieri, che ci dice che la letteratura tratta e modella ogni sorta di eccezione all’ipotesi di razionalità e di perfetta informazione.
Quel che conta, e ben dovrebbero saperlo gli economisti, non è quel che fanno nei loro studi, dove vedono tutto, per carità, ma è la vulgata della teoria che viene trasmessa e che ha bisogno di prodotti pronti per l’uso. Ben se ne accorsero Keynes e gli economisti keynesiani quando la vulgata keynesiana diventò volgare, se ne dovrebbero accorgere, oggi, gli economisti di altra confessione”.
Spaventa prosegue, quindi, dando due esempi di recepimento di proposizioni economiche nella vulgata.
Il concetto interessante è questo: gli economisti (così mi pare di capire da quanto dice Spaventa) non dovrebbero limitarsi a produrre teorie e spiegazioni aderenti alla realtà. Dovrebbero occuparsi anche di come questi modelli vengono recepiti e tradotti in strumenti concreti di intervento (la vulgata) e, quindi, delle conseguenze pratiche del loro pensiero.
E, quindi, di come il loro pensiero impatta sullo Zeitgeist, sullo spirito del tempo.
Mi capita spesso di parlare di modelli, e di sottolineare come ogni modello sia, in sé, un riduttore di complessità. La contropartita di questa riduzione della complessità è la disponibilità di strumenti concreti di intervento sulla realtà che il modello stesso descrive (e, in questo senso, interpreta).
Direi che Spaventa percorre la stessa strada, pur da premesse diverse.
Mi pare un concetto fecondo di conseguenze, e, naturalmente, valido non soltanto per gli economisti.
Che ne dite?
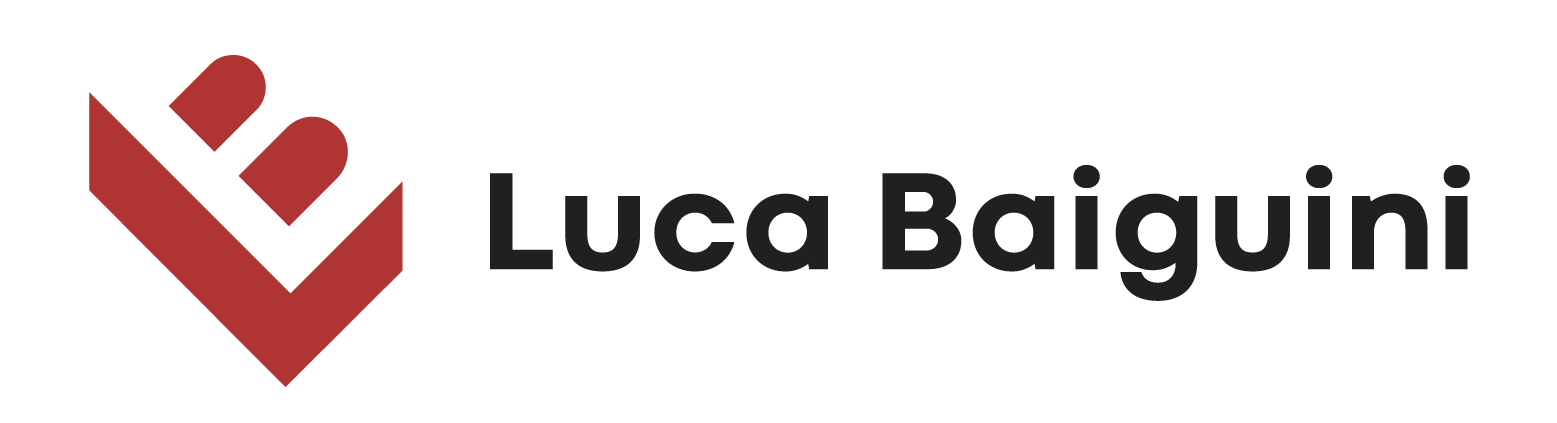
Interessante.