Come si discuteva nel Gruppo 63
Avevo già scritto che, tra i libri di queste vacanze, c’è “Costruire il nemico” di Umberto Eco.
Condivido uno spunto che mi è parso interessante: Eco parla del clima e della modalità di interazione che si veniva a creare nei ritrovi palermitani del Gruppo 63:
Eppure le persone convenute a Palermo erano accomunate sia da una volontà di sperimentazione che da una esigenza di dialogo rissoso, senza pietà e senza infingimenti. Gli scrittori si leggevano i testi a vicenda ma, dato che c’erano fratture originarie, nessuna lettura fatta riscuoteva il consenso generale. Non ci si dichiarava perplessi: ci si diceva contro. E si diceva il perché. Quali fossero i perché non conta. Conta che in questa società letteraria l’unità si stava realizzando a poco a poco attraverso due implicite assunzioni di metodo: (i) ogni autore sentiva necessario controllare la sua ricerca sottoponendola alle reazioni altrui; (ii) la collaborazione si manifestava come assenza di pietà e di indulgenza.
Correvano definizioni da levare la pelle agli animi troppo sensibili. Espresso pubblicamente nell’ambito di una società letteraria apollinea, ciascuno di questi giudizi avrebbe segnato la fine di una bella amicizia. A Palermo il dissenso generava invece amicizia.
Ecco, mi pare una descrizione piuttosto precisa di quanto intendevo dire qui.
E le due assunzioni di cui parla Eco sono presupposti essenziali perché questo tipo di processo funzioni: la disponibilità al confronto (e la percezione della sua necessità) e – io traduco così la seconda assunzione – la consapevolezza condivisa che in questo tipo di processi si sta “recitando una parte”, e che, quindi, anche l’attacco più diretto ha come fine il miglioramento del prodotto (in questo caso letterario) finale.
Se vigono queste assunzioni, il dissenso può arrivare a generare amicizia.
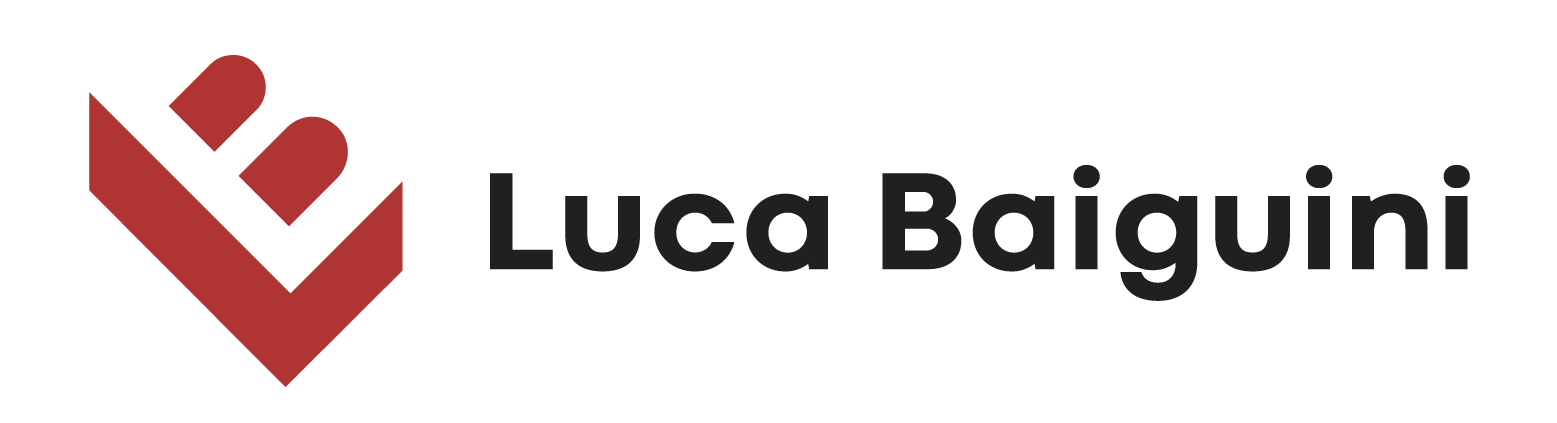
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!