Ciò che non siamo, ciò che non vogliamo
Un commento critico al mio ultimo post mi ha suscitato alcune riflessioni. Roberto se la prende con chi fa il mestiere di formatore e di coach, e con me in particolare.
Un paio di premesse (non difese, ma precisazioni):
- Roberto sostiene che si specula per vendere consulenza, corsi e libri. Nel mio caso, quanto scrivo qui non ha l’obiettivo di vendere consulenza, perché io non ne faccio se non molto occasionalmente: mi occupo di formazione. Inoltre, svolgo la stragrande maggioranza del mio lavoro all’interno di due consorzi partecipati dal Politecnico di Milano: MIP e Cefriel. Non “vendo”, quindi, direttamente. Al limite si può dire che il mio obiettivo sia quello di guadagnare e mantenere la fiducia di questi due “committenti”, ma mi pare cosa molto diversa da quanto ipotizza Roberto. Direi che “docente”, nel mio caso, è una definizione più aderente di quella di “formatore”.
- Per quanto riguarda il coaching, non lo pratico: non ne ho le competenze e, al momento, non mi interessa svilupparle.
Detto questo, però, il commento mi provoca, perché mette in evidenza rischi reali del mio mestiere. E mi sa che a volte dentro a questi rischi ci sono cascato.
Così in questi giorni ci ho pensato su un po’.
Non ho conclusioni da portare, soltanto due pensieri che mi hanno guidato nella riflessione.
Il primo è di Jacques Lacan, che un giorno ha detto:
Un pazzo che si crede un re è pazzo, ma un re che si crede un re è ancora più pazzo.
Non so se interpreto correttamente questo pensiero, ma mi pare ci dica che, in fondo, il delirio è sempre delirio dell’io, a qualsiasi livello si manifesti. Quindi, il formatore che si crede formatore è pazzo di quel delirio che fa credere di possedere soluzioni e di esserne portatore. L’essenza del mio mestiere dovrebbe essere, invece (così almeno io credo), l’offerta di opportunità per allargare le opzioni e le possibilità da un lato, e dall’altro la condivisione di criteri di scelta tra queste possibilità. Altrove ho chiamato questi due movimenti logica della varietà e logica dell’appropriatezza. Senza, appunto, un io al centro.
Il secondo sono i famosi ultimi versi di una poesia di Eugenio Montale:
Non domandarci la formula che mondi possa aprirti
sì qualche storta sillaba e secca come un ramo.
Codesto solo oggi possiamo dirti,
ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.
Non vorrei scomodare il poeta per una quisquilia, ma in questi giorni mi sono detto che se avessi pensato di più a ciò che non sono e ciò che non voglio essere (e meno a quello che credo di essere e che credo di volere), qualche stupidaggine l’avrei evitata. E non sto parlando solo del mio lavoro.
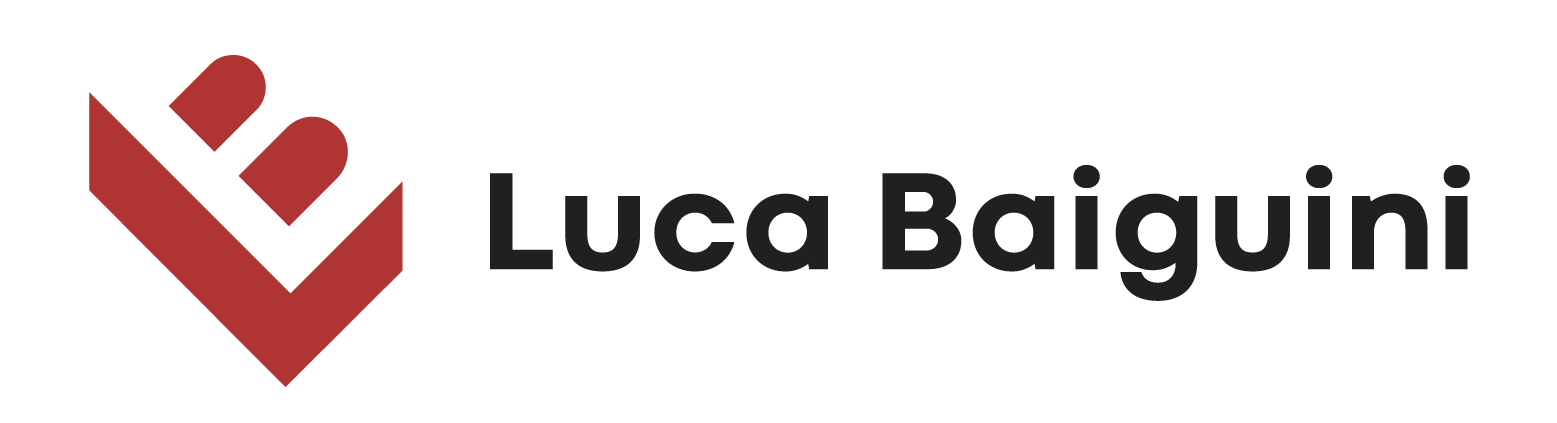
Ho letto tutto e con l’attenzione che meritava.
Non mi è riuscito di capire il nesso tra le tue osservazioni e la risposta di Roberto. Forse Roberto aveva urgenza di manifestare una sua , sicuramente motivata, irritazione.
Poiché anche io faccio questo mestiere mi sono sentita parte in causa. Io tra l’altro non lo faccio all’interno di una struttura come l’Università per cui non ho proprio scampo: non sono docente (lo sono stata in passato, a lungo e capisco la differenza), ora non lo sono più.
Parto da un punto della risposta di Luca: “L’essenza del mio mestiere dovrebbe essere, invece (così almeno io credo), l’offerta di opportunità per allargare le opzioni e le possibilità da un lato, e dall’altro la condivisione di criteri di scelta tra queste possibilità.”
Ecco in queste parole mi riconosco, con tutti i limiti e le incertezze di questo ruolo.
Diciamo che quando lavoro “insieme” alle persone che si affidano alla mia competenza sono un osservatore esperto e consapevole di comportamenti e atteggiamenti che caratterizzano l’agire umano soprattutto nei luoghi di lavoro. Il mio ruolo è quello di aiutarli a individuare i possibili cambiamenti che potrebbero permettere loro di essere più efficaci e di lavorare in un clima più “disteso” e qualche volta piacevole.
Mostrare, indicare come innescare un circuito positivo di benessere e crescita. Poi ogni singola persona e i gruppi sono e rimangono liberi di scegliere come utilizzare quello che accade in un’aula di formazione: io posso indicare una strada, accendere qualche luce per “vedere” più e meglio, il cammino è e rimane una loro libera scelta, una loro responsabilità.
Tutto questo riesce solo se io mi mantengo a latere, da parte, se sono così brava da lasciare a loro, che devono agire il cambiamento, il ruolo di protagonisti, se il mio “io” è marginale rispetto al loro percorso, se l’ascolto prevale sul dire.
Ricordo uno spettacolo del regista polacco Cantor: “Wielopole, Wielopole”: nello spettacolo lui metteva in scena la sua memoria ed era pure presente sulla scena, ma silenzioso ed appartato si limitava ad indicare con qualche gesto agli attori cosa fare, lasciando a loro il ruolo di protagonisti. Ora mi pare una buona metafora del mio lavoro.
Poi è chiaro che a me, come a chiunque, capita di sbagliare, di deludere, di essere insufficiente.
Un’ultima osservazione: noi speculiamo se non siamo onesti, ma come tutte le persone che mettono in gioco competenze capacità ed esperienza da “professionisti” è anche chiaro che queste capacità e competenze le vendiamo, come fa un avvocato o il cuoco di un ristorante, il parrucchiere o un maestro di sci o chiunque lavori e crei lavoro a partire da se stesso e da quello che sa fare: i clienti che mi cercano o non mi cercano più sono coloro che hanno il compito di valutare il valore di quello che faccio. Io faccio di tutto perché siano soddisfatti e vedano concretamente i risultati del lavoro fatto insieme, ma se puntassi a creare “dipendenza“ per continuare a vendere formazione, sarei come un medico o uno psicologo che mantenessero il paziente malato per continuare a curarlo: profondamente disonesti. Questo è un aspetto che ha una rilevanza etica e rimanda appunto all’onestà di ciascuno.
Non so se sono riuscita a spiegare il mio pensiero, sicuramente ci sarebbero molte altre cose da dire, molte osservazioni, ma voglio fermarmi qui, magari la discussione può continuare.
Grazie Giulia per il tuo commento, profondo e circostanziato. Mi ritrovo in particolare nelle ultime righe, quando parli di dipendenza. Credo che anche questa sia una chiave di lettura rilevante.